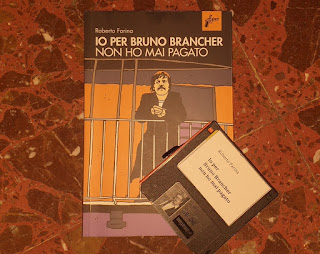M. Nucci, Achille e Odisseo. La ferocia e l'inganno,
Einaudi
La penna di Nucci è fedele a se stessa e
riconoscibilissima: chi ha letto Le lacrime degli eroi e L'abisso di Eros sa
che Nucci è promessa di scrittura altissima.
Questo libro è a metà strada tra il romanzo e il
saggio e, allora, si sogna, si impara,
ci si conferma nell'estasi dell'innamoramento: Achille resta sempre il
leone e Odisseo non può che essere il polpo. A pagina 87, ho pianto:"La fragilità degli eroi. Perché non esiste
uomo realizzato che non si sia misurato con le proprie debolezze. Al punto che
si potrebbe stabilire una legge che agli appassionati di supereroi e agli
illusi dell’invincibilità degli antichi personaggi mitici potrebbe risultare
completamente indigesta. Solo chi conosce le proprie debolezze può dirsi uomo.
Solo chi è davvero pronto alla sconfitta può ambire all’espressione completa della
propria umanità: l’eroismo”.
G. Montefoschi,
Desiderio, La nave di Teseo
Nel bel mezzo di relazioni disciplinari, relazioni
coordinate di classe, giudizi e numeri,
volevo un romanzo leggero, che mi distraesse: mi sono ritrovata a
leggere Desiderio.
Trama un po' obsoleta: l'amore che sopravvive a
tutto e che si intreccia a gelosie, dolori, malattia, ossessione della
malattia. Bugie, radici, traumi. Buon
romanzo, scritto in una bella lingua italiana, ma troppi personaggi. Roma
splende ovunque. Il passaggio più bello è a pagina 153: “Avrebbe voluto dirle che l’amava, non aveva smesso neppure un giorno
d’amarla, era stato il suo unico amore; che gli anni nei quali erano stati
lontani potevano cancellarli in un istante; che la sofferenza atroce dalla quale
era stato annichilito, pure quella era sparita, non esisteva più; che gli
occhiali lo avevano commosso, tutto lo commuoveva di lei: le calze tirate, i
tacchi alti, i meravigliosi occhi neri, le labbra dischiuse che spasimava di
baciare per ritrovare il sapore che non aveva dimenticato mai; che lo avrebbe
fatto immediatamente, se non ci fossero stati quei ragazzini con le biciclette,
le mamme con le carrozzine, i passanti, ma che era bello pure così: non pensare
a nulla, stare vicini…”.
G.Ritsos, Bianche macule sopra il bianco, Torri del
vento.
Ghiannis Ritsos è monumentale, in tutto ciò che Egli
è e ha scritto. Quando mi è capitato per la prima volta di leggere una sua
poesia mi trovavo ad Atene, era il 2015, cercavo notizie sul teatro che avevo
appena visto sulla strada che percorrevo, mentre aspetto la mia moussakà in una
taberna e mi imbatto su internet in una poesia: c'è chi naviga poi ci sono io
avvezza ai naufragi.
La poesia era tratta Erotica e così creduto che si trattasse di un “amoroso” e,
poiché ingabbiata in un amore senza capo né coda e poiché tutto mi sentivo
tranne che adulta, volli leggere Erotica e feci l'ordine su Amazon, così al mio
entro in Italia avrei trovato il libro a casa. Questo per dire che tutte le più
grandi passioni nascono nell’assoluta incoscienza. Erotica non era che la punta
di un iceberg bollente fatto di mitologia, di resistenza, di amore per gli
altri, di dolore, ma soprattutto di una tale potenza di esistere che mi ha
guarita da tutte quelle pochezza nelle quali quotidianamente mi imbrigliavo.
Nel 2016 mi sono dovuta di colpo inventare adulta, ho smesso di essere figlia,
ho conosciuto la morte e lì, ancora una volta, Ritsos è stato la catena che mi
ha tenuta stretta all’esistenza. Ho letto tutto ciò che di Ritsos è stato
tradotto in italiano: sono certa che con Ritsos, appena mi sentirò pronta,
imparerò il neogreco.
Intanto quest’estate, due nuove pubblicazioni di
Ritsos (oramai le sue opere sono per lo più introvabili!) hanno arricchito la
mia anima: la prima è proprio BIANCHE MACULE SOPRA IL BIANCO. Si tratta di 110
poesie tradotte da M. Caracausi.
Ci sono gli oggetti di Ritsos, c’è il suo sguardo
che placa il mondo, c’è il dolore che tace e la pace naturale, c’è il bianco
che acceca, il bianco che accoglie, il bianco che vomita la tempesta. C’è
l’amore, c’è la morte. C’è la bellezza.
“Dentro i miei
sogni
sempre tu,
con una bicicletta,
con un albero,
con lo specchio.
Togliti una buona volta
dai capelli
questa rosa.
Io
inchiodo le mie carte
con una stella
perché non me le porti via il vento”.
G. Ritsos, Molto tardi nella notte, Crocetti editore
Opera capolavoro, ultima raccolta di Ritsos,
composta tra il 1987 e il 1989 a Samo.
È la raccolta più cupa di Ritsos, una sorta di
“appressamento della morte”, ma anche una specie di lascito dell’essenziale. La
traduzione di Nicola Crocetti è strepitosa, musicale, aspra e dolce al tempo
stesso.
È la poesia delle “Assenze”:
Bella donna silenziosa, dall’incedere
lento,
avvolta nella porpora della sera
tra due pavoni dalle code aperte.
Fuori della porta, le grandi galosce infangate
del guardaboschi. E sopra le alberature
occhieggia una piccola luna balbuziente.
Ora dovrai parlare tu al suo posto,
ma le parole mancano a poesie già dette.
E’ il luogo dell’oblio (Oh, anni infantili dimenticati,/anni senza sospetti, ipnotizzati dal
bel sole/ tra due miracoli ignoti. Il grande libro/ era chiuso sulla sedia di
paglia del giardino).
È la poesia del tempo, delle rivoluzioni lontane,
della tristezza sottratta all’uomo dai giorni d’estate:
Un’altra estate
Questi bei giorni di sole sottraggono
ogni argomento alla tristezza.
Baluginano le case calcinate sparse sulla collina verde.
Ecco, anche un cavallo rosso nella piana. Ma erano veri
quella ragazza nel campo di granturco e quel ragazzo
nell’oro del meriggio che faceva segno al battello di passaggio
con l’asciugamano da bagno. Eri vero
anche tu che credevi alla musica e non avevi niente di tuo
se non quello che donavi, e forse quello che donerai ancora.
(Karlovasi, 25.VII.87)
L’ultima estate
Dicono addio i colori dei tramonti. È
tempo di preparare
le tre valigie-i libri, le carte, le camicie-
e non scordare quella veste rosa che ti stava così bene
anche se d’inverno non la indosserai. Io,
nei pochi giorni che ancora ci restano, riguarderò
i versi scritti in luglio e agosto,
anche se temo di non avere aggiunto niente, semmai
di avere sottratto molto, poiché da ess traspare
l’oscuro sospetto che questa estate
con le sue cicale, i suoi alberi, il mare,
coi fischi delle navi nei tramonti gloriosi,
coi barcaioli sotto i balconi al chiar di luna
e con la sua misericordia ipocrita, sarà l’ultima.
(Karlovasi, 3.IX.89)
È la poesia della lenta stanchezza, degli addii. Ed
è sintesi straordinaria della produzione di Ritsos. È l’opera aspettata da
anni, cercata, introvabile. È carne, sangue e spirito. Ritsos andrebbe
ASCOLTATO in tutte le scuole del creato, insieme al battito del proprio cuore.
V. Perrin, Cambiare l’acqua ai fiori, edizioni e/o
Romanzo femminile, storia di una madre-Violette- e
di una figlia –Leonine; storia del più grande dei dolori, della forza di
ricominciare; storia di una casa davanti ad un cimitero, più viva di qualunque
altro luogo.
Romanzo sul senso di esistere che va cercato nella quotidiana cura di un
giardino sacro, sul senso dell’amicizia profonda, della passione che devasta,
delle vite cominciate storte da raddrizzare.
La salvezza viene dal mare. E così ogni risposta.
Non aggiungo altro: solo che Sasha vorrei
incontrarlo anch’io, un giorno o l’altro.
Questo romanzo lascia addosso una dolcezza che sa di
“cannella”: sembra sia un best seller, meno male che non lo sapevo, forse non
lo avrei scelto.
O. Kessel Pace, Scilla. Racconto mitologico, Città
del Sole edizioni
È una “favoletta”. Semplice semplice. Per chi vuole
conoscere il mito di Scilla e l’amore di Glauco. C’è qualche errore
(reinterpretazione?) nella descrizione dell’isola di Eea, che pare
popolatissima, in barba alla solitudine della maga Circe.
Meno male che si legge in un’ora scarsa.
S. Veronesi, Il colibrì, La nave di Teseo
Non leggo quasi mai “chi vince”, preferisco di gran lunga i “vinti”: questa
volta ho approfittato delle vacanze e un altro romanzo ci stava nelle mie
letture.
Il colibrì è una sequela di tragedie che consumano i
giorni del dottor Marco Carrera; alle tragedie si aggiungono detti, non detti,
famiglie solo apparentemente sane, profondamente segnate da incomprensioni,
silenzi, omissioni, compromessi, sensi di colpa. C’è il grande, strano, muto,
difficile triangolo Marco-Luisa-Giacomo (il fratello di Marco); c’è la morte di
Irene, la follia di Marina e c’è, soprattutto, il rapporto esclusivo di Marco
con sua figlia Adele, che mette al mondo Miraijin, poco prima di andarsene via
per sempre. Finale struggente, con una morale di speranza: pur rimanendo
APPARENTEMENTE fermi, si cambia e, nonostante dolori inenarrabili, c’è-e resta
sempre- qualcosa di buono che può salvare il mondo. È un romanzo “strano”.
Triste. Eppure pieno di luce.